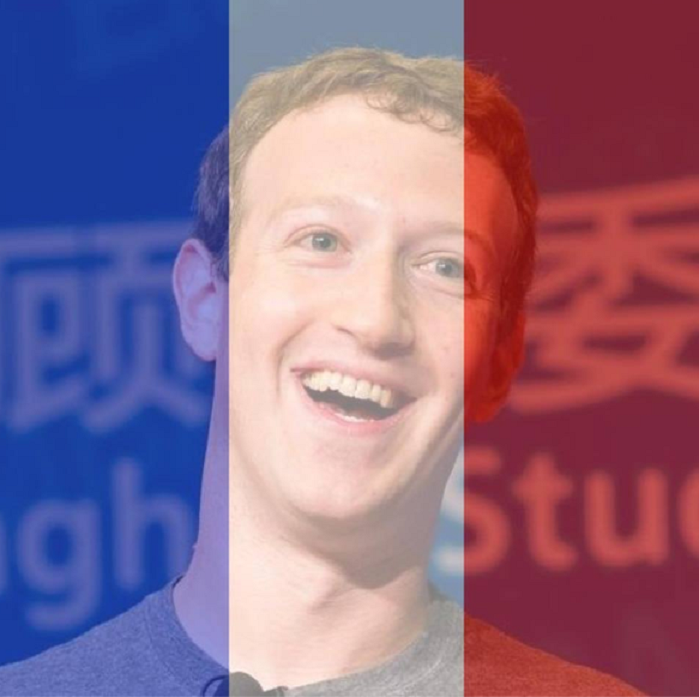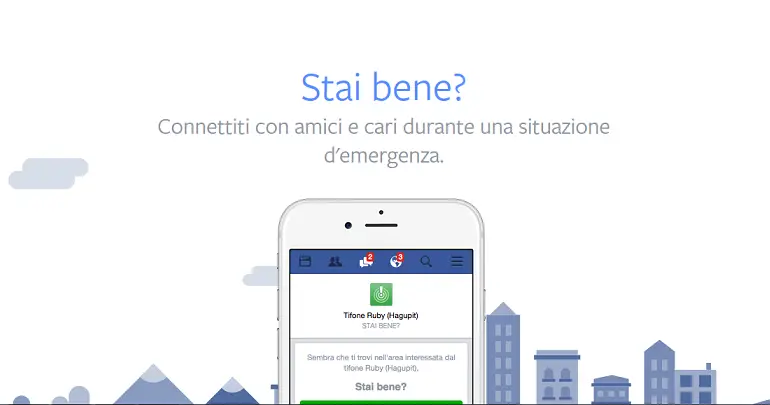Safety Check e foto profilo per Parigi: gli esperimenti di Zuckerberg svelano la nostra miseria digitale
Lo scorso venerdì sera, mentre Parigi veniva sconvolta da una serie di ignobili attentati e ancora si andava misurando l’entità della carneficina, su Facebook cominciava ad apparire con una certa insistenza una singolare notifica: il tale o il talaltro utente «ha confermato di stare bene durante Attacchi terroristici a Parigi»; o ancora, nella versione impersonale da Iperuranio digitale: «è stato confermato che l’utente x sta bene durante Attacchi terroristici a Parigi».
Si trattava del Safety Check di Facebook, un servizio attivato fin dallo tsunami in Giappone del 2011 per mettere in contatto le persone impossibilitate ad utilizzare le linee telefoniche intasate o saltate in caso di calamità naturali e ora esteso per la prima volta anche a un disastro causato dalla barbarie umana. L’esperimento, almeno sotto un profilo meramente numerico, è stato un successo, visto che oltre 4 milioni di persone hanno usato il servizio e 360 milioni di utenti hanno ricevuto la notifica.
Di primo acchito, sopraffatto da un male sempre più banale e indicibile e travolto dall’alluvione mediatica, il popolo del web non ci ha badato più di tanto. In fondo, hanno pensato in molti, è una funzione utile, che sfrutta la porosità della rete e la sua resistenza al collasso per permettere alle persone di comunicare ai loro cari che stanno bene. Qualcuno, forse, ha percepito inconsciamente come qualcosa non quadrasse, ma senza riuscire a metterlo a fuoco razionalmente. E poi, di fronte al disumano che si incarna in azioni umane, che peso può mai avere una semplice funzione su un social network? E però le parole un peso lo hanno sempre, perchè racchiudono interi mondi e celano dietro di sè le concezioni dominanti dell’uomo e della società.
Così, già nel weekend, quando ancora si contavano e si piangevano i morti parigini, qualcuno ha giustamente cominciato a domandarsi: perchè per Parigi sì e per Beirut, dove giovedì sono morte 40 persone, no? Perchè i morti occidentali meritano un safety button e le esternazioni a tarda notte dei potenti del mondo, mentre i morti libanesi – o nigeriani, pakistani, curdi – sono condannati alla seconda classe, al silenzio della Storia? La polemica è diventata virale, tant’è che Zuckerberg è dovuto correre ai ripari con un suo status personale:
«Molte persone si sono chieste giustamente perchè abbiamo attivato il Safety Check per Parigi ma non per i bombardamenti a Beirut e in altre parti del mondo», scriveva Zuckerberg sabato. «Fino a ieri, la nostra policy prevedeva di attivare il Safety Check solo per le calamità naturali. Abbiamo deciso di cambiare questa policy e pianifichiamo di adottarla per ulteriori disastri umani, andando avanti. […] Avete ragione, ci sono molti altri importanti conflitti nel mondo. Noi teniamo a tutte le persone in egual modo e lavoreremo duramente per aiutare il più possibile chi soffre in situazioni analoghe a questa».
La giustificazione del Ceo di Facebook e Whatsapp è parsa a molti quantomeno tardiva o tirata per i capelli (perchè il cambio di policy non è avvenuto giovedì per Beirut?), ma non è il punto su cui vorremmo soffermarci. Quella che ci preme fare, è invece una considerazione di carattere semiotico. Sì, perchè rileggendo a mente fredda le frasi impiegate nella pagina del Safety Check, quella sensazione di disagio prende finalmente corpo. Semioticamente, quelle concatenazioni di significanti rappresentano un piccolo orrore all’interno dell’orrore. Certo, nessuno nega la potenziale utilità della funzione. E sì, purtroppo abitiamo una società talmente complessa da costringerci (o almeno incoraggiarci fortemente) a vivere quotidianamente una serie di contraddizioni piccole e grandi, non ultima quella di criticare un social network dal social network stesso, quando potremmo benissimo non iscriverci o abbandonarlo.
Ciò che è però semioticamente contestabile a questa versione del Safety Check sono due cose, fondamentalmente:
- l’assenza di articolo davanti a “Attacchi terroristici a Parigi”, come pure il metafisico “è stato confermato che”, ci pare costituiscano una sorta di normalizzazione e banalizzazione dell’orrore. Quella stringa di testo è fungibile, e di fatto funziona in modo analogo a qualunque altro evento Facebook. Un passo più in là, e ci si potrebbe spingere a un «x è commosso durante Attacchi terroristici a Parigi», «y ha partecipato a Attacchi terroristici a Parigi», «a z piace o non piace Attacchi terroristici a Parigi».
- A differenza della linea telefonica, il traffico dati non collassa, è vero. Ma allora perchè non pubblicare uno status elaborato col proprio cervello o, meglio ancora, mandare un messaggio privato e individualizzato ai propri cari? Dopo una tragedia, norrmalmente il primo pensiero è di mettersi in contatto con le persone che contano sul serio nella propria vita. Non con 5.000 “amici” Fb. Altrimenti il sospetto è che si tratti della consueta spettacolarizzazione da agorà virtuale, che svilisce l’intimità del dolore e crea un’assuefazione quasi voyeuristica a tali mostruosità.
E infine, due parole sulla funzione che invita alla modifica della foto profilo, «per sostenere la Francia e i cittadini di Parigi». Qualcosa di simile era stato già fatto dopo la storica decisione della Corte Suprema Usa sui matrimoni gay, ma allora si trattava di un evento lieto (per molti, almeno). Anche qui, apparentemente, come non essere d’accordo a tingere le proprie foto del tricolore francese?
Eppure anche questa decisione crea dei dispositivi di inclusione/esclusione. Implica sempre che ci siano vite dal valore infinito e altre, sostanzialmente tutte quelle alle periferie del grande impero eurocentrico, per cui in fondo è normale essere spazzate via come formiche. Perchè non si è pensato alla stessa funzione per la bandiera libanese, o di tutti gli altri Stati flagellati dall’Isis?
Ma soprattutto, in un mondo dove le dinamiche dirimenti passano sopra le nostre teste e dove specialmente le giovani generazioni sono relegate a esperire il consesso sociale in universi virtuali, questi escamotage da anime belle finiscono per rivelarsi per quello che sono: un surrogato della politica e dell’engagement, buoni per beccare qualche like facile, per quietare la nostra coscienza turbata e per sentirci parte di una comunità immaginata, almeno finchè la paura tiene alta l’attenzione. In attesa della prossima tragedia, perchè intanto i nostri selfie tricolori non avranno modificato nulla. Al massimo, avranno contribuito a quell’enorme esperimento sociologico e di marketing che Mark Zuckerberg va inseguendo da anni con il suo giocattolino.
Photo © Mark Zuckerberg – Facebook